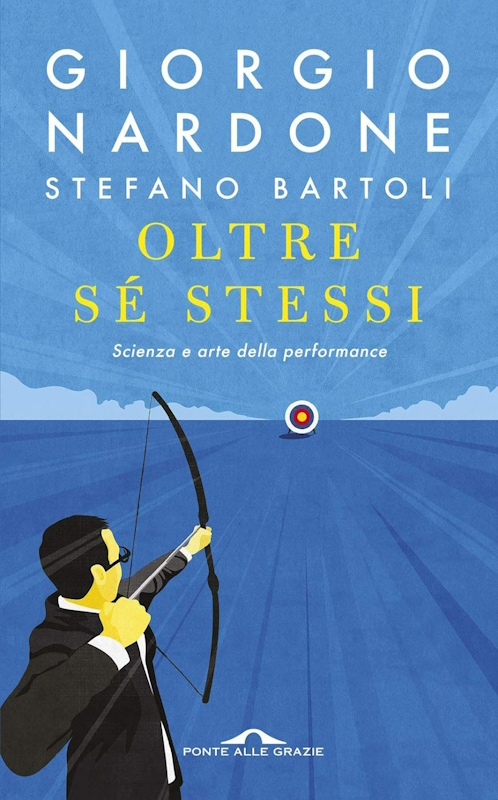Benefici delle buone letture
Leggere per proprio conto o ascoltare delle letture,oltre a darci piacere può davvero aiutarci a vivere meglio. La lettura ad alta voce ben fatta, ha in più il vantaggio di farci sentire meno soli, anche quando non viene da una persona presente accanto a noi, ma da un CD o dalla radio. Se è in forma di racconto, inoltre, viene capita e memorizzata meglio, perché tocca delle corde affettive, che le fredde spiegazioni sono incapaci di stimolare. Dato che il buonumore è determinante per la riuscita di qualunque cosa, dai pensieri alle azioni, ecco che i vantaggi di una lettura ad alta voce sono da tenere in considerazione particolare. Anche per facilitare il sonno, l’ascolto di una voce che racconta qualcosa di piacevole è determinante, perché fa reagire come i bambini a cui si racconta una favola per farli addormentare. Tutto questo influisce sulla salute, perché sposta l’attenzione da qualcosa di nocivo o comunque doloroso e favorisce il coraggio di prendere decisioni positive. Se la lettura è di racconti o romanzi che ci coinvolgono nelle vicende dei protagonisti, ci identifichiamo in loro che diventano un po’ come dei buoni amici o una famiglia che magari nella realtà non abbiamo. Se invece ci fa conoscere cose nuove e ci fa capire ciò che ancora aveva una forma indistinta, riceviamo una spinta interiore che ci vivifica. Un testo stimolante mette in moto le idee ed è molto utile per trovare vie nuove. Quindi MENO MEDICINE, PIU’ LIBRI in ogni età.
Ma come scegliere un buon libro e magari un bravo narratore o narratrice? A volte è molto difficile, ma possiamo fare una prova e vedere qual’è l’effetto. Se produce gioia, entusiasmo, voglia di fare altrettanto, buona disposizione verso gli altri, ci sono molte probabilità che faccia per noi e forse abbia anche delle qualità che si possano considerare buone per tante altre persone.
Il link alle recensioni di narrativa e di saggistica che aiutano a capire l’animo umano si trovano qui
I miei libri si trovano qui
*********************
Il mondo interiore è importante quanto quello che ci circonda. Ecco perché questo sito si occupa di entrambi